
Da grande voglio fare il “salatore”
Da maggio 2025 giro come una trottola per tutta l’Italia svolgendo audit di terza parte e spesso i voli di rientro per la Sicilia subiscono ritardi importanti. Durante le attese, tra i passeggeri si creano piccole comunità con profonda empatia, dove scambiarsi informazioni, sensazioni e raccomandazioni.
Qualche settimana fa, rientrando da Napoli, durante il consueto ritardo di Wizz Air si è formata un piccolo gruppo composto da coppie, lavoratrici e lavoratori pendolari e giovani che cercano fortuna fuori dalla Sicilia. Uno di loro, un ragazzo di 20 anni, classe media, studente, alla domanda «Perché sei a Napoli?» mi risponde: «Ho fatto il test per poliziotto!». Io, scherzando, dico: «Con tanti mestieri che potevi scegliere… proprio poliziotto?!» E lui replica: «È la mia ambizione».

In questo articolo voglio concentrarmi su alcuni mestieri “nascosti”, ambiti e richiesti dall’industria alimentare, che rischiano di scomparire o perdere identità a causa del progresso selvaggio. Si tratta di mestieri che rafforzano la biodiversità, danno identità e ricchezza ai territori e offrono stimoli imprenditoriali ai giovani del sud.
Oltre che occuparmi di sicurezza alimentare, coltivo uno spiccato interesse per la cultura popolare legata alla trasformazione e alla conservazione degli alimenti, in particolare per le olive da mensa e per l’olio extravergine di oliva. Alimenti che parlano del territorio e portano con sé un po’ di magia che nasce forse dal fatto che conservano un’incertezza – dovuta a fattori tecnologici e agronomici – che contribuisce alla creazione della loro identità sensoriale.

Nella foto, il frantoiano dell’Oleificio Guccione Sas di Chiaramonte Gulfi (RG) intento a valutare la gramolazione della pasta di olive
Ogni frantoio di successo ha una figura di riferimento durante il periodo della molitura: il frantoiano. Le sue mansioni non sono limitate alla direzione dei macchinari, ma partecipa alle manutenzioni prima della campagna, al settaggio degli impianti durante i collaudi e, alla fine, contribuisce alla pulizia e allo smontaggio. Non è un semplice meccanico: conosce le olive del territorio, la provenienza di ciascuna e tutela il carattere varietale, permettendo a ogni cultivar di esprimersi al meglio. Il frantoiano decide la velocità del frangitore e la dimensione della griglia, regola temperatura e tempi di gramolazione, calibra la velocità e la distanza delle bocche di uscita del decanter, sa quando pulire la linea e riconosce subito se un macchinario non lavora come dovrebbe.
Spesso, assaggiando oli monovarietali in diversi frantoi, riesco a sentire “il frantoiano”: lo percepisco in una Biancolilla dolce e leggermente piccante o in una Cerasuola dal gusto morbido e piacevole.
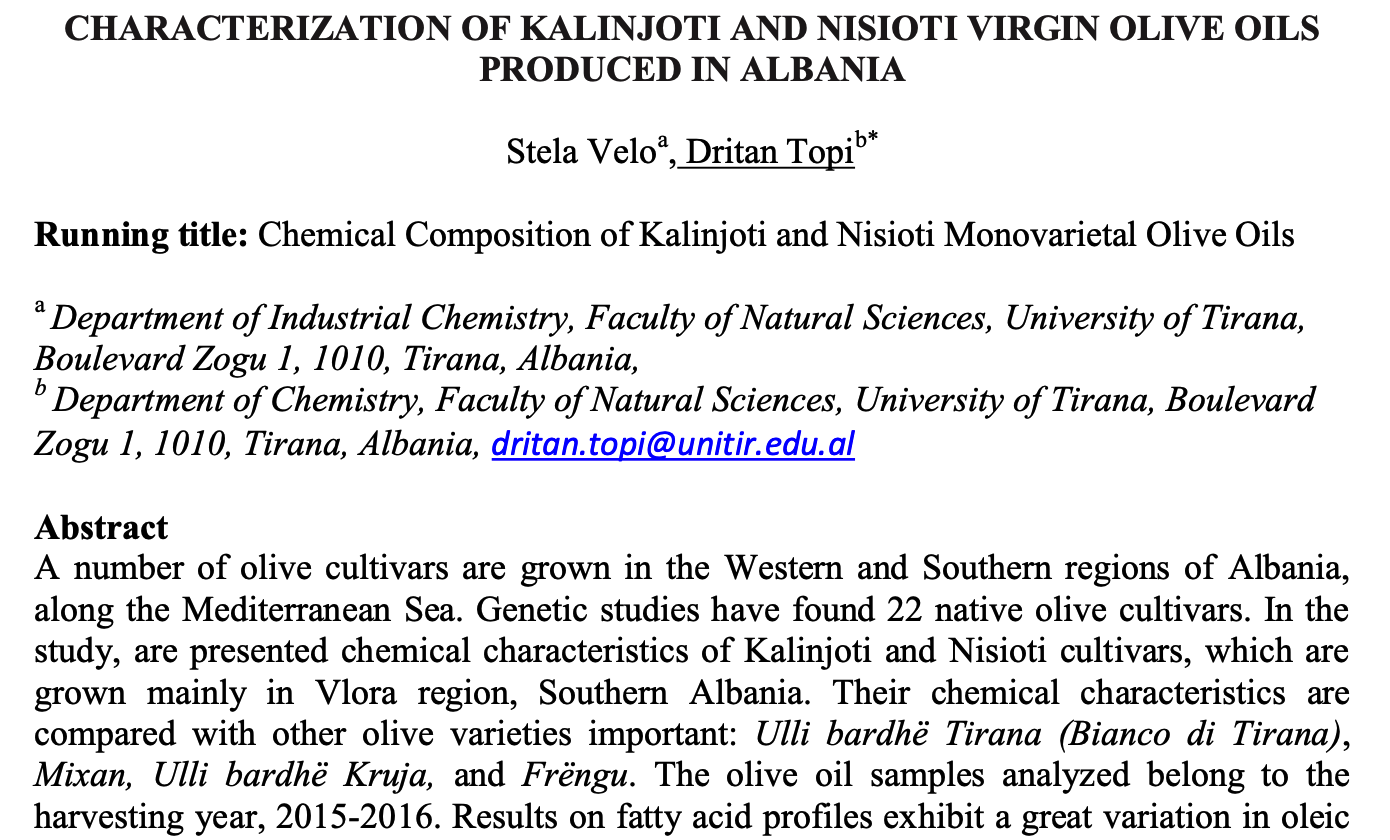
Da qualche mese, esporto i miei servizi di consulenza in Albania, paese in forte crescita anche dal punto di vista olivicolo. Anche loro, come la Grecia, vanta di una cultura popolare olivicola antica e una biodiversità consistente con oltre 22 varietà di ulivi!!! Ho assaggiato diversi oli alcuni con un carattere deciso e con profumi e sapori diversi dai nostri, tutti di buona qualità. Nonostante i frantoi albanesi siano tecnologicamente avanzati, faticano a valorizzare appieno le 22 varietà autoctone presenti nel territorio. Gli imprenditori hanno spesso difficoltà a trovare persone capaci di far funzionare al meglio i frantoi. Oggi le innovazioni tecnologiche corrono più veloci della formazione di tecnici in grado di gestirle.

Restando nell’ambito olivicolo, un mestiere simile a quello del frantoiano è quello del salatore. Ho sentito parlare per la prima volta di questa figura durante un confronto tecnico con alcuni olivicoltori del Catanese che volevano produrre olive in salamoia con le proprie olive. Ogni azienda produttrice di olive da mensa ha il suo salatore, spesso il titolare stesso, che decide — in base all’annata, al grado di maturazione, all’andamento climatico e alle caratteristiche desiderate del prodotto finito — la percentuale di sale da utilizzare nei vari passaggi, le modalità di integrazione della salamoia nei fusti (in Sicilia si usano raramente fermentatori industriali) e riesce a capire, semplicemente osservando un’oliva, se il processo di fermentazione sta procedendo correttamente. A differenza dell’olio, le olive da mensa sono il risultato di un processo fermentativo che, se non condotto in modo adeguato, può generare prodotti potenzialmente pericolosi.
In Sicilia la produzione di olive da mensa è concentrata in due aree principali: la Valle del Belice, con la Nocellara del Belice, e i versanti dell’Etna, con la Nocellara dell’Etna (in zone non ancora convertite a pistacchieti e vigneti). Due varietà vicine, due territori vicini, ma due prodotti completamente diversi: nel primo caso si utilizza il metodo Castelvetrano, che prevede una fase iniziale di “cottura” in soda e successiva fermentazione; nel secondo si adotta il metodo naturale o greco, che utilizza soltanto sale per selezionare i microrganismi (soprattutto lieviti e batteri lattici) responsabili dell’addolcimento naturale delle olive.
Questi mestieri, all’interno di un’azienda, generano fatturato, ma all’interno di un territorio portano biodiversità — rendendo possibile la lavorazione di varietà minori o meno conosciute — insieme a ricchezza e imprenditorialità sana. Sono mestieri unici, difficili da imparare, ma che una volta appresi non si dimenticano più: un po’ come andare in bicicletta.
